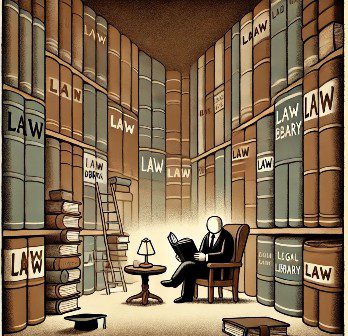La sicurezza della pena (e l’insicurezza del diritto): viaggio nel panpenalismo costituzionalmente scorretto
Non tutto ciò che è legge è giusto, non tutto ciò che rassicura è sicurezza, e non tutto ciò che punisce protegge davvero.
Nel cuore della giurisprudenza costituzionale italiana, accade talvolta che la ragione sussurri dove il diritto penale grida. Ed è proprio a questo punto di rottura—tra il rumore del decreto sicurezza e il sussiego delle corti—che il Massimario della Suprema Corte prova a introdurre un ordine, o quantomeno un rilievo strutturato, in quel paesaggio sempre più simile a una discarica simbolica della legalità penale che ad oggi prende il nome di decreto sicurezza.
Link alla relazione in calce
Il diritto penale come analgesico sociale
Siamo davanti a un uso del diritto penale non come extrema ratio, ma come prima linea di difesa simbolica del potere. Una strategia che rasenta il paradosso: mentre il sistema giudiziario annaspa sotto il peso dei processi e delle carceri sovraffollate, si continua ad alimentare l’idea che più reati e più carcere equivalgano a più sicurezza. È una superstizione politica, non una razionalità giuridica.
Il tema è arcinoto e insieme drammaticamente attuale: il d.l. n. 48/2025, figlio non riconosciuto ma perfettamente somigliante di una lunga tradizione di emergenzialismo normativo, tenta il colpo grosso—riplasmare la geografia delle libertà fondamentali in nome di un concetto magmatico e politicamente pirotecnico: la sicurezza. Il problema? Lo fa sacrificando, come agnelli sull’altare della propaganda, principi costituzionali che dovrebbero essere la bussola del legislatore, non la posta della sua roulette legislativa.
Già in apertura, il Massimario, in un lampo quasi lirico, fotografa lo spirito dei tempi: «non solo concretamente possibile […] ma addirittura desiderabile arrivare a sacrificare o comunque limitare l’esercizio di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti». È una dichiarazione che, nella sua crudezza, pare più adatta a un manifesto di Machiavelli sotto acido che a un decreto dello Stato di diritto.
La Corte costituzionale, dal canto suo, non resta muta. Anzi, il suo profluvio giurisprudenziale suona come una sinfonia interrotta da continue note a piè di pagina. Eppure, tra le righe delle sue decisioni più recenti (n. 74/2025, n. 46/2024, n. 86/2024, n. 116/2024 e via discorrendo), si intravede un’irritazione sottile, quasi una pedagogia esasperata: la discrezionalità del legislatore non equivale ad arbitrio. Una banalità? Forse. Ma ripetuta con tale insistenza da far supporre che qualcuno, nel palazzo, abbia seriamente bisogno che glielo si ricordi.
Tu suggeriamo anche: Diritto di Critica
La legalità svuotata di contenuto
Il richiamo ai grandi principi – legalità, determinatezza, proporzionalità – suona quasi rituale, un incantesimo stanco che tenta di arginare l’esondazione simbolica della pena. Ma quando bisogna ribadire che “la discrezionalità non è arbitrio” in ogni decisione, forse vuol dire che qualcuno al potere lo ha dimenticato. O peggio, finge di non capirlo.
Il panpenalismo del decreto sicurezza come progetto politico
Non è solo un difetto tecnico: è un progetto. Il panpenalismo diventa il linguaggio ufficiale di una politica che ha rinunciato a governare le cause e si limita a reprimere gli effetti. Colpire il dissenso, punire la marginalità, soffocare lo sciopero: non sono incidenti di percorso, sono scelte sistemiche. E il diritto, se non resiste, diventa complice.
L’architettura concettuale del decreto sicurezza, infatti, pare costruita su un’idea di pena come totem sociale, più che come risposta ponderata a condotte lesive. Il principio di proporzionalità è evocato come un mantra svuotato, mentre la legalità penale—quella vera, fatta di tassatività e determinatezza—viene sospinta ai margini da norme che sembrano scritte con l’evidenziatore emotivo anziché con la penna giuridica.
La responsabilità penale d’autore—quella che trasforma l’essere in colpa per ciò che si è, non per ciò che si fa—torna con inquietante nonchalance. Secondo la Corte (n. 116/2024), è inammissibile. Secondo il legislatore d’urgenza, è invece materia di innovazione creativa, purché mascherata dietro parole che brillano di autorità e ordine. I nuovi reati e le nuove aggravanti, disseminati come mine nel testo del decreto, colpiscono più la condizione soggettiva dell’imputato che la lesività oggettiva della sua condotta.
Leggi anche: Il ragionevole dubbio
Il pericolo dell’“eccezione normalizzata”
Il decreto sicurezza del 2025, come molti altri prima di lui, nasce sotto l’egida dell’urgenza. Ma la “norma d’emergenza” è ormai la vera norma generale. In questo scenario, l’eccezione diventa abitudine, e il diritto costituzionale rischia di restare un fossile in bella mostra sui manuali universitari, mentre fuori si vive una realtà repressiva “a norma di legge”.
La critica più feroce—e più lucida—viene però da quell’universo spesso dimenticato nei talk show securitari: la dottrina. Penalisti, costituzionalisti, magistrati e avvocatura hanno composto una sinfonia dissonante contro quella che è stata definita senza mezzi termini ipertrofia penalistica. Il diritto penale, qui, diventa spettacolo: un teatro dell’ossessione securitaria, dove la legge è scenografia e il giudice comparsa.
È il trionfo della “logica del more of the same”, come l’ha definita una parte della dottrina: a ogni problema sociale si risponde con un’aggravante, ogni dissenso con una nuova fattispecie incriminatrice, ogni luogo di protesta con un’aggravante “di contesto”. Il locus commissi delicti non è più solo dato tecnico: è diventato criterio semiotico per selezionare i “nemici” da colpire.
E così, lo spettro dell’illegittimità costituzionale torna a infestare ogni riga del decreto. Il principio di offensività è ignorato: le nuove fattispecie, in astratto, sembrano colpire più un’ansia collettiva che un danno reale. Il principio di sussidiarietà penale è travolto da un entusiasmo normativo da stato di guerra (sociale). La determinazione delle pene scivola via dalla logica del trattamento individualizzato, per abbracciare la rassicurante geometria del “tanto peggio, tanto più carcere”.
Nel mirino finiscono, in particolare, le libertà costituzionali: quella di manifestare (art. 21 Cost.), quella di riunirsi (art. 17), e persino il diritto di sciopero (art. 40). Il diritto penale come clava preventiva, agitata là dove il dissenso si fa visibile, rumoroso, incivile. Insomma: politico.
È un’idea punitiva che ha il sapore dello stato etico in versione securitaria, in cui la paura diventa leva legislativa e la pena diventa sedativo collettivo. Ma a che costo? Come ricorda la Corte costituzionale, l’aumento sanzionatorio indiscriminato non solo rischia di violare la proporzionalità, ma finisce per inceppare il sistema processuale: più reati, più processi, più carcere. E meno giustizia.
Nell’eco della tradizione giuridica italiana, queste dinamiche dovrebbero suonare stonate. Eppure, l’apparato normativo del d.l. 48/2025 sembra coltivare con zelo l’illusione terapeutico-punitiva della pena simbolica. Come nota Vigneri, siamo davanti a un diritto penale che non cura, ma mima; non corregge, ma reprime; non protegge, ma rassicura. Per finta.
La critica dottrinaria: potente ma isolata
Il fatto che la critica più lucida e penetrante provenga dall’accademia e dalla magistratura testimonia una cosa: che nel mondo giuridico italiano esiste ancora un presidio critico forte. Ma resta una voce nel deserto. Il dibattito pubblico, fagocitato da slogan e retoriche da talk show, raramente ospita questa voce. E senza un ponte tra pensiero giuridico e opinione pubblica, anche la Costituzione rischia di essere una bella carta, ma inutile.
E allora, cosa resta al giurista? Secondo il Massimario, l’“ufficio giurista”—quella strana figura a metà tra l’esegeta e il guardiano del senso costituzionale—deve rimanere vigile. Pena il tradimento. Tradimento non solo della funzione tecnica del diritto, ma di quel patto implicito che la Costituzione stabilisce con i suoi interpreti: mai piegare la legge al bisogno di consenso. Mai sacrificare la libertà sull’altare della paura.
Il problema, forse, è che oggi più che mai il diritto penale non è un’arma, ma un selfie legislativo: uno strumento di identità politica, buono per i titoli dei giornali, per i post, per la propaganda. Peccato che, nel frattempo, ci si dimentichi di un dettaglio: la legalità è ancora (formalmente) un valore costituzionale.
E forse, a ben vedere, anche un diritto umano.
Relazione su novità normativa n. 33 del 2025