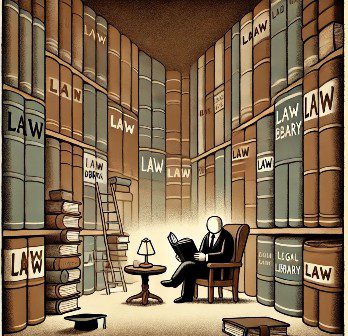«La proprietà si può lasciare». Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza nr. 23093 sulla rinuncia abdicativa ripercorrono la storia, il sistema, i limiti e le ricadute pratiche
La decisione delle Sezioni Unite affronta una disputa ultracentenaria: è ammissibile la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare? La risposta è sì, come atto unilaterale, non recettizio, espresso e trascrivibile, che determina ex lege l’acquisto a titolo originario da parte dello Stato ai sensi dell’art. 827 c.c. La Corte, tuttavia, delimita con precisione il perimetro del sindacato giudiziale: non è consentito al giudice dichiarare la nullità “virtuale” per contrasto con la funzione sociale dell’art. 42 Cost., né evocare un generico abuso del diritto o l’illiceità del motivo/corrispettivo. Restano vivi, invece, gli ordinari strumenti di tutela (ad es. azione revocatoria dei creditori) e i divieti posti da norme imperative speciali (ambientali, urbanistiche, sicurezza). La corte con questa lunga ed articolata sentenza arriva ad enunciare due principi di diritto.
La questione proveniva dalla rinuncia effettuata da un proprietario di un fondo classificato come a rischio geologico elevato e si trattava di terreni sostanzialmente inservibili e privi di valore economico in quanto, come emergente dal certificato di destinazione urbanistica, tutti sottoposti a Vincolo Pericolosità elevata P2 del Piano di Assetto Idrogeologico predisposto dalla Regione Abruzzo. Il Ministero dell’economia e delle finanze e dall’Agenzia del demanio hanno cercato, così, di ottenere la declaratoria di nullità dell’atto.
Sentenza in calce
La domanda di fondo e il contesto del rinvio pregiudiziale sulla rinuncia abdicativa
La questione arriva alle Sezioni Unite attraverso i rinvii del Tribunale di L’Aquila (e in parallelo del Tribunale di Venezia). Il nodo è se il proprietario possa spogliarsi unilateralmente della proprietà immobiliare — non trasferendola a terzi, ma abdicarvi — con l’effetto di lasciare il bene “acefalo” e, dunque, vacante. L’art. 827 c.c. prevede che i beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato (o della Regione nei casi statutari speciali).
La giurisprudenza e la dottrina si divaricano in due filoni:
Tesi favorevole: rinuncia ammissibile come negozio unilaterale non recettizio, non traslativo, desumibile — tra l’altro — dagli artt. 827, 1350 n. 5 e 2643 n. 5 c.c. (forma e trascrizione delle rinunce a diritti reali). L’effetto sui terzi è solo indiretto.
Quindi, questo filome, reputa ammissibile la rinuncia abdicativa alla proprietà, argomentando dagli artt. 827, 1118 comma 2, 1350 n. 5) e 2643 n. 5 del codice civile. La rinuncia abdicativa alla proprietà darebbe luogo, per questa tesi, ad un negozio giuridico unilaterale, non recettizio, né traslativo (a differenza delle ipotesi di c.d. abbandono liberatorio, di cui agli artt. 550, 882, 1070 e 1104 del codice civile), con effetti soltanto indiretti sui terzi.
Tesi contraria: le ipotesi codicistiche di rinuncia (ad es. artt. 550, 882, 963, 1070, 1104, 2814 c.c.) sarebbero eccezioni tipizzate (traslative o liberatorie) e l’art. 827 c.c. avrebbe funzione di norma di chiusura: gli immobili non possono restare sine domino; la rinuncia non può lasciare un “vuoto”.
L’opinione avversa ravvisa, quindi, nelle norme citate ipotesi, comunque, di rinunce traslative o liberatorie, oppure deroghe giustificate dal diverso regime delle cose comuni, richiama le ulteriori disposizioni contenute negli artt. 963 e 2814 del codice civile e spiega l’art. 827 cod. civ. come disposizione “di chiusura”, desumendone che i beni immobili, a differenza delle cose mobili, non possono essere di “proprietà di alcuno”. Secondo questa impostazione, tutte le fattispecie in cui il codice civile ha espressamente ammesso la rinunzia ad un diritto reale risultano accomunate dal dato che, a fronte di essa, la proprietà immobiliare non rimane “acefala”, perché in tali casi la rinunzia provoca l’estinzione del diritto reale minore e la correlativa riespansione della piena proprietà, ovvero, trattandosi di diritti reali minori in comunione, provoca l’accrescimento delle quote altrui sul diritto reale minore.
La concreta vicenda di L’Aquila e Venezia ha come sfondo immobili gravati da vincoli conformativi (stabilità idrogeologica, tutela del territorio), cioè beni diseconomici per il privato.
Approfondisci: La Facoltà Abdicativa del Diritto di Proprietà
Evoluzione storica della rinuncia abdicativa, dalla derelictio romana alla modernità documentale
Nel diritto romano classico, la derelictio copriva anche gli immobili; si discuteva se, oltre a volontà e abbandono materiale, servisse l’occupazione di un terzo. Con la modernità, le legislazioni hanno condizionato la rinuncia a forme pubbliche (scrittura + trascrizione nel codice del 1865, o iscrizione nei libri fondiari su modello germanico).
Già la dottrina di inizio ’900 ne evidenziava la funzione economico-sociale: liberarsi di fondi non solo infruttuosi ma dannosi.
Se per il diritto romano classico la rinuncia alla proprietà degli immobili era compresa nella più ampia facoltà di derelictio, discutendosi soltanto se oltre la volontà del proprietario e l’effettivo abbandono della cosa occorresse altresì l’occupazione del bene da parte di un terzo, il diritto moderno ha preso ad interessarsene essenzialmente per condizionarne la validità ad una dichiarazione in forma scritta da rendere pubblica mediante trascrizione (ad esempio, art. 1314, n. 3, del codice civile 1865) o, nelle legislazioni di tipo germanico, mediante iscrizione nei libri fondiari. Già oltre un secolo fa, si affermava in dottrina che la rarità dei casi in cui potesse avvenire una rinuncia del titolare alla proprietà di un immobile giustificava che l’ordinamento civilistico ne limitasse la disciplina alla previsione di specifiche formalità, senza curarsi di regolare più nel dettaglio tale modo di dismissione, pur avvertendo che detta rinuncia serve a soddisfare l’esigenza, tutt’altro che infrequente, di disfarsi di fondi la cui gestione risulti non soltanto infruttuosa, ma anche dannosa. È questa la situazione che sembra accomunare le due vicende oggetto dei giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di L’Aquila e al Tribunale di Venezia. Gli immobili su cui vertono le due cause risultano sottoposti a vincoli conformativi della proprietà privata finalizzati alla tutela dell’interesse pubblico alla stabilità e alla difesa dell’assetto idrogeologico del territorio, il che comporta la prescrizione di limiti ed obblighi alle rispettive facoltà dominicali.
Le obiezioni al centro del dibattito
La rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare rappresenta un istituto atipico: nessuna norma lo prevede espressamente, e tuttavia il sistema giuridico non la vieta, anzi ne richiede la forma e la trascrizione ai sensi degli artt. 1350 n. 5 e 2643 n. 5 c.c.. Tale disposizione conferma la possibilità di dismettere volontariamente un bene, purché rispettati i requisiti di pubblicità e formalità previsti per gli atti dispositivi.
Spesso si invoca la funzione sociale della proprietà ex art. 42 Cost., ipotizzando un dovere di permanenza del proprietario, soprattutto per beni onerosi o dispendiosi. Tuttavia, le limitazioni alla proprietà per finalità sociali costituiscono una riserva di legge e non spettano al giudice: la rinuncia “egoistica” non viola di per sé alcuna norma costituzionale.
Un’altra preoccupazione riguarda lo scarico degli oneri sullo Stato, ad esempio per la messa in sicurezza o la bonifica dei beni vacanti. Occorre sottolineare che l’acquisizione statale avviene ex lege e a titolo originario, e non configura un trasferimento contrattuale di obblighi. Le responsabilità pregresse rimangono a carico del rinunciante, mentre quelle successive gravano sul nuovo titolare.
Il tema dell’abuso del diritto o di atti emulativi è spesso evocato quando la rinuncia appare finalizzata a nuocere o a eludere obblighi. Tuttavia, l’abuso richiede un interesse positivo ulteriore; la rinuncia, al contrario, esprime un interesse negativo, volto semplicemente a disfarsi del bene. L’art. 833 c.c. sanziona solo gli atti privi di qualsiasi vantaggio, mentre la rinuncia costituisce una modalità tipica di disposizione del patrimonio.
Infine, si è discusso dell’impatto sull’equilibrio di bilancio ex art. 81 Cost., temendo un carico eccessivo sul patrimonio pubblico. Tuttavia, l’art. 81 Cost. non condiziona la validità dell’autonomia privata, ma costituisce semmai un criterio di legittimità delle leggi. Resta salva la possibilità per il legislatore di rimodulare la disciplina dei beni vacanti, senza incidere sul diritto di rinunciare.
In conclusione, la rinuncia abdicativa si configura come un atto legittimo, formalmente regolamentato e giuridicamente tutelato, la cui disciplina è delimitata dalla riserva di legge e dalla funzione di tutela dei terzi e del patrimonio pubblico.
Il percorso argomentativo delle Sezioni Unite passa dalla Proprietà, godimento e disposizione
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la rinuncia va letta alla luce dell’art. 832 c.c., ossia come un’espressione del potere di disporre della proprietà e di scegliere la destinazione economica del bene. Possedere un bene non significa solo goderne o trarne vantaggio: implica anche la facoltà di rinunciarvi, quando il proprietario decide che non intende più sostenerne oneri o responsabilità. Pensiamo, ad esempio, a un terreno agricolo divenuto improduttivo: la rinuncia legittima consente di sottrarre al proprietario l’obbligo di manutenzione senza che venga meno il principio di proprietà.
Ovviamente c’è una distinzione tra Beni mobili e immobili
La distinzione tra mobili e immobili è cruciale. Per i beni mobili, la rinuncia si realizza attraverso la derelizione con occupazione, secondo l’art. 923 c.c.: basta abbandonare la cosa in modo visibile affinché chi la trovi possa acquistarne la proprietà. Gli immobili, invece, richiedono formalità più rigorose: un atto scritto e trascritto, poiché l’abbandono materiale, come lasciare una casa o un terreno incolto, non produce effetti abdicativi. L’effetto della rinuncia nasce dall’atto formale, mentre l’acquisizione statale avviene ex lege, dal momento della vacanza del bene. Ad esempio, un palazzo storico lasciato vuoto non diventa automaticamente proprietà dello Stato finché non vi sia la trascrizione della rinuncia.
Abbandono liberatorio ≠ rinuncia abdicativa
I casi tipici (artt. 882, 963, 1070, 1104 c.c. e altri) perseguono la liberazione da obbligazioni connesse alla cosa. La rinuncia abdicativa, invece, mira solo a dismettere il diritto. Occorre distinguere la rinuncia abdicativa dagli abbandoni liberatori previsti da specifiche norme (artt. 882, 963, 1070, 1104 c.c. e altre). Questi ultimi perseguono l’obiettivo di liberare il proprietario da obblighi connessi al bene, come la manutenzione, il pagamento di canoni o la responsabilità per danni. La rinuncia abdicativa, invece, ha un solo scopo: disfarsi del diritto di proprietà, senza che vi sia necessariamente un vincolo di liberazione da obblighi pregressi. Un esempio pratico è la rinuncia a un terreno contaminato: non si tratta di un abbandono per sottrarsi a doveri, ma di una scelta di non mantenere più la titolarità del bene.
Limiti esterni: norme imperative, non “morali”
Il giudice non può creare ex novo limiti di validità dalla funzione sociale; ove il legislatore voglia limitare rinunce a immobili diseconomici, deve farlo esplicitamente. Il giudice non può inventare limiti alla validità della rinuncia basandosi sulla funzione sociale della proprietà o su motivazioni morali. Se il legislatore intende circoscrivere le rinunce, ad esempio per immobili particolarmente dispendiosi o di interesse pubblico, deve farlo esplicitamente, attraverso norme chiare. La legge è dunque l’unico filtro che può vincolare l’autonomia privata in questo ambito.
Responsabilità e tutela dei terzi
La rinuncia non cancella responsabilità pregresse (danni da rovina, custodia, inquinamento). Dopo la rinuncia, lo Stato assume obblighi propter rem solo per il futuro; la P.A. conserva strumenti di rivalsa (Cass. 199/2024) e rimedi amministrativi/ambientali. Quindi la rinuncia non estingue le responsabilità pregresse: eventuali danni da rovina, custodia o inquinamento restano a carico del rinunciante. Successivamente, lo Stato assume gli obblighi propter rem solo per il futuro, senza sostituire automaticamente il proprietario in tutte le responsabilità pregresse. La pubblica amministrazione conserva strumenti di rivalsa e può intervenire con rimedi amministrativi o ambientali, come confermato dalla Cass. 199/2024. Ad esempio, se un ex proprietario ha lasciato un capannone industriale inquinato, egli resta responsabile per le opere di bonifica pregresse, mentre lo Stato si occupa solo della gestione futura.
Il perimetro del sindacato giudiziale sulla rinuncia abdicativa
La rinuncia alla proprietà non è priva di controlli. I creditori del rinunciante, ad esempio, possono agire con l’azione revocatoria, poiché la rinuncia può ridurre la garanzia patrimoniale a loro disposizione. Allo stesso modo, il giudice verifica la conformità a norme imperative, come quelle ambientali, edilizie o di sicurezza: una rinuncia non può diventare uno strumento per eludere obblighi normativi specifici. Ad esempio, non si può rinunciare a un terreno industriale contaminato per sottrarsi agli obblighi di bonifica previsti dalla legge.
Al contrario, non è ammesso dichiarare la nullità della rinuncia invocando generici principi costituzionali, come l’art. 42 Cost., né configurarla automaticamente come abuso o atto emulativo. La rinuncia, infatti, è un esercizio tipico del diritto di disporre della proprietà: un gesto legittimo di disposizione, anche se motivato da ragioni economiche o personali, e non può essere interpretato come illecito di per sé.
Da ciò deriva una conseguenza metodologica fondamentale: il giudice non può imporre al privato un “dovere di essere e restare proprietario” per motivi generici di interesse pubblico o sociale. Qualsiasi limite alla libertà di rinunciare deve provenire esclusivamente dalla legge, che può stabilire condizioni specifiche per tutelare interessi collettivi o garantire la sicurezza, senza sostituirsi alla volontà del proprietario.
Un esempio pratico rende chiaro questo principio: se un cittadino possiede un edificio fatiscente e decide di rinunciarvi, il giudice non può vietarglielo solo perché l’immobile potrebbe avere un valore storico o sociale. Eventuali vincoli, come l’obbligo di conservazione per motivi urbanistici o ambientali, devono essere previsti dalla legge, non creati ex novo dalla giurisprudenza.
Conseguenza metodologica: il giudice non può imporre al privato un “dovere di essere e restare proprietario” per generici motivi di interesse generale. Se limiti devono esservi, li pone la legge.
I due principi di diritto enunciati
La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, espressivo della facoltà di disporre (art. 832 c.c.), avente funzione abdicativa (dismissione del diritto). Dalla vacanza del bene consegue ex lege l’acquisto a titolo originario dello Stato (art. 827 c.c.). La rinuncia trova causa in sé, non richiede l’adesione di un altro contraente.
Se la rinuncia appare animata da “fine egoistico”, il giudice non può dichiararne la nullità (né virtuale per art. 42 Cost., né per illiceità di causa/motivo), perché i limiti a tutela della funzione sociale spettano al legislatore. Non è configurabile abuso della rinuncia come atto dominicale diretto alla perdita del diritto.
Principi enunciati
1) La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’art. 832 cod. civ., realizzatrice dell’interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare ‹‹trova causa››, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell’interesse perseguito, in sé stessa, e non nell’adesione di un ‹‹altro contraente››.
2) Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un «fine egoistico», non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall’art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di interesse generale». Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l’interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato.
Riflessioni pratiche
La pronuncia delle Sezioni Unite chiarisce definitivamente che la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare è un atto legittimo, disciplinato dal codice civile e dal principio di autonomia privata, purché rispettati forma e trascrizione. In sintesi: La rinuncia è unilaterale, non recettizia e ex lege produce effetti di acquisizione originaria dello Stato. Il giudice non può annullarla sulla base di motivi di interesse generale o funzione sociale; i limiti spettano al legislatore. Gli obblighi pregressi del rinunciante non vengono meno; quelli futuri gravano sul nuovo titolare. L’atto è efficace anche in assenza di accettazione statale, ma resta vincolato ai divieti di legge e agli strumenti di tutela dei terzi (revocatoria, norme imperative).
Il quadro normativo e giurisprudenziale delineato rende la rinuncia abdicativa uno strumento concreto per la gestione di beni immobili dispendiosi, rischiosi o gravati da obblighi, pur mantenendo la tutela del patrimonio pubblico e dei creditori.
Note e riferimenti normativi
- Codice Civile: artt. 827, 832, 923, 1350 n. 5, 2643 n. 5, 550, 882, 963, 1070, 1104, 2814, 2051, 2053.
- Codice Penale: art. 633.
- Costituzione: artt. 42, 81.
- Giurisprudenza nazionale: Cass. 28 maggio 1996, n. 4945; Cass. 2 marzo 2007, n. 4975; Cass. 27 gennaio 1976, n. 256; Cass. 4 gennaio 2024, n. 199; Sez. Unite 10 giugno 1988, nn. 3940–3946; Sez. Unite 15 novembre 2022, nn. 33645 e 33659.
- Corte Costituzionale: 24 ottobre 2007, n. 348; 27 febbraio 2024, n. 28; n. 165/2023, n. 44/2021, n. 274/2017, n. 184/2016.
- Strumenti internazionali: Carta dei Diritti UE, art. 17; Protocollo n. 1 CEDU, art. 1.
Il quadro normativo di riferimento
- Art. 832 c.c.: proprietà = godere e disporre “in modo pieno ed esclusivo”, entro i limiti di legge.
- Art. 827 c.c.: gli immobili “non in proprietà di alcuno” spettano allo Stato; acquisto a titolo originario.
- Art. 1350 n. 5 c.c.: forma scritta ad substantiam per gli atti di rinuncia a diritti reali immobiliari.
- Art. 2643 n. 5 c.c.: trascrivibilità delle rinunce a diritti reali su immobili.
- Artt. 550, 882, 963, 1070, 1104, 2814 c.c.: rinunce tipizzate (liberatorie o traslative) che non lasciano vacanza proprietaria.
- Art. 923 c.c.: derelizione/occupazione solo per cose mobili (chiara la differenza con gli immobili).
- Art. 633 c.p.: tutela penale anche per immobili abbandonati: lo stato di abbandono non estingue lo ius excludendi alios.
- Costituzione, art. 42: riconoscimento/garanzia della proprietà e funzione sociale (con riserva di legge); Carta dei diritti UE, art. 17; Protocollo n. 1 CEDU, art. 1.
Giurisprudenza richiamata (nazionale e sovranazionale)
- Cass. 28 maggio 1996, n. 4945: distinguere rinuncia agli effetti dell’usucapione dalla rinuncia alla proprietà; no rinuncia tacita alla proprietà (salvo casi tipici come art. 1070 c.c.).
- Sez. Unite 10 giugno 1988, nn. 3940–3946: sull’“abbandono liberatorio”: è gratuito e libera da oneri, ma non può surrettiziamente produrre effetti traslativi o far sorgere acquisti coattivi; la vacanza genera l’attribuzione ex art. 827 c.c.
- Cass. 2 marzo 2007, n. 4975; 27 gennaio 1976, n. 256: art. 827 c.c. come acquisto originario legato alla vacanza.
- Sez. Unite 15 novembre 2022, nn. 33645 e 33659: lo jus disponendi non è solo vendita: comprende la scelta di destinazione del bene.
- Corte cost. 27 febbraio 2024, n. 28: l’art. 633 c.p. si applica anche ad edifici abbandonati; l’abbandono non annulla lo ius excludendi alios né è imposto dalla funzione sociale.
- Corte cost. 24 ottobre 2007, n. 348; 28 luglio 1983, n. 252; 28 aprile 1994, n. 166; 29 dicembre 1995, n. 529; 23 aprile 1986, n. 108; 30 aprile 2015, n. 71: trama costituzionale della proprietà come diritto soggettivo con limiti di legge, non come funzione pubblica.
- Cass. 4 gennaio 2024, n. 199: spese di bonifica ambientale e rivalsa della P.A.; obbligazione indennitaria ex lege in chiave di sussidiarietà verticale.
- Responsabilità extracontrattuale: art. 2051 e 2053 c.c.; Cass. 7 agosto 2013, n. 18855; Cass. 16 luglio 1966, n. 1924; Cass. 3 marzo 1965, n. 360.
- Vincoli di finanza pubblica (art. 81 Cost.): Corte cost. n. 165/2023, n. 44/2021, n. 274/2017, n. 184/2016.