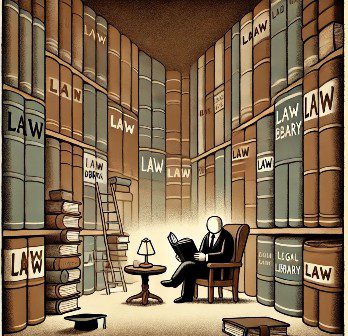Un nuovo snodo nella disciplina dei CPR
La sentenza n. 96 del 2025 della Corte costituzionale si inserisce con forza nel solco delle decisioni che, pur non determinando effetti caducatori immediati, segnano un punto di svolta nel rapporto tra fonti normative, diritti fondamentali e prerogative del legislatore. In particolare, essa investe il cuore della disciplina dei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR), portando alla luce un vulnus costituzionale strutturale: l’assenza di una disciplina legislativa primaria sui “modi” del trattenimento amministrativo, in contrasto con la riserva assoluta di legge di cui all’art. 13, secondo comma, della Costituzione.
Il presente contributo intende offrire un’analisi approfondita delle ricadute sistemiche della pronuncia, soffermandosi su tre piani: i primi orientamenti giurisprudenziali successivi alla decisione, le implicazioni sistemiche e costituzionali del modello delle sentenze di “illegittimità accertata ma non dichiarata”, e, soprattutto, la tensione tra permanenza formale della norma e sua sostanziale disapplicabilità alla luce del vulnus riconosciuto. In un contesto in cui il trattenimento amministrativo tocca direttamente la sfera più sensibile dei diritti umani, il monito della Consulta si traduce in una chiamata alla responsabilità collettiva dell’ordinamento.

Approfondisci la sentenza con l’Articolo: Corte Costituzionale, Sentenza n. 96/2025 CPR
La sentenza n. 96/2025: un vulnus accertato, ma non sanzionato
Con la sentenza in esame, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate sull’art. 14, comma 2, del Testo unico sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998), affermando tuttavia con estrema chiarezza l’inadeguatezza della disciplina vigente rispetto al dettato costituzionale. Il trattenimento amministrativo, quale misura incidentale sulla libertà personale, richiede una disciplina primaria sui “modi” di esecuzione: una condizione che la normativa vigente, basata su fonti secondarie e atti amministrativi, non soddisfa.
Pur evitando una pronuncia di accoglimento per l’assenza di “rime adeguate”, la Consulta sollecita con forza un intervento legislativo, inaugurando una dinamica che travalica la classica dialettica tra Corte e Parlamento. Il giudice delle leggi, in altri termini, accerta la lesione costituzionale ma non la sanziona formalmente: un approccio che pone in tensione la funzione di garanzia della Corte e le esigenze sistemiche di certezza del diritto. In questo modo, si introduce una nuova prassi giurisprudenziale: la Corte agisce come regolatore del sistema, esercitando una pressione costituzionale che si traduce in atti politici, più che giuridici, nel tentativo di stimolare un processo riformatore.
Le prime reazioni della giurisprudenza di merito: obiter dicta e tentativi di sistematizzazione
Le pronunce delle Corti d’appello di Sassari, Roma e Genova, sebbene motivate da elementi estranei alla sentenza n. 96/2025 (inidoneità sanitaria, condizioni di vulnerabilità, tardività del provvedimento), colgono la portata della pronuncia della Corte costituzionale e la inseriscono nei rispettivi ragionamenti decisori. Questa integrazione rappresenta un primo tentativo di concretizzare i principi enunciati dalla Corte, anche in assenza di un’esplicita riforma normativa.
In particolare, la Corte d’appello di Sassari afferma esplicitamente che, in assenza di una disciplina primaria dei “modi” del trattenimento, si determina una riespansione del diritto alla libertà personale, che nessuna fonte secondaria può validamente comprimere. Si tratta di un’obiter dictum che si fa quasi ratio decidendi, suggerendo un percorso argomentativo in grado di sospingere il giudice comune verso una forma di disapplicazione indiretta della disciplina subprimaria, con l’effetto di aprire una via inedita verso la tutela effettiva dei diritti delle persone trattenute.
Analogamente, la Corte di Roma e quella di Genova valorizzano la sentenza n. 96/2025 come parametro ermeneutico, affermando che, pur senza declaratoria di incostituzionalità, essa impone una lettura costituzionalmente orientata dei presupposti per la convalida del trattenimento. Tale approccio crea un effetto domino: la giurisprudenza comincia a interrogarsi non solo sulla legalità formale dei provvedimenti, ma sulla loro compatibilità sostanziale con i principi supremi dell’ordinamento.
Le ricadute sistemiche: tra legalità sostanziale e paralisi normativa
Il vero punto critico della sentenza è però sistemico. Essa lascia inalterata una disciplina che lo stesso giudice delle leggi considera inadeguata. Il legislatore, vero destinatario della decisione, è chiamato a intervenire con urgenza per evitare che si consolidi una situazione di illegalità costituzionale diffusa. Ma nelle more, che strumenti ha il giudice comune?
Il rischio è quello di un corto circuito: la norma resta formalmente in vigore, ma è sostanzialmente delegittimata. L’effetto è una frattura tra la legalità formale e quella sostanziale, che può condurre alla paralisi applicativa. In assenza di una disciplina primaria, ogni “modo” di trattenimento è potenzialmente privo di copertura legale. Il giudice si trova così a decidere se dare prevalenza alla permanenza normativa o alla lesione riconosciuta. L’alternativa tra fedeltà alla norma vigente e fedeltà alla Costituzione diventa più che mai concreta.
Ciò che ne deriva è una tensione crescente tra le esigenze di efficienza dell’azione amministrativa e le esigenze di tutela dei diritti fondamentali. Il rischio è quello di un diritto amministrativo “a costituzionalità debole”, in cui la discrezionalità si muove su un terreno incerto, esposto a derive arbitrarie e privo di un solido fondamento legislativo.
Le sentenze di incostituzionalità accertata ma non dichiarata: natura, limiti, rischi
Il modello decisionale adottato nella sentenza n. 96/2025 non è inedito. Già con la sentenza n. 22/2022 sulle REMS, la Corte aveva tracciato la via della pronuncia “a monito”, in cui si accerta l’illegittimità ma si evita l’accoglimento per evitare vuoti normativi e lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore.
Tuttavia, questo modello pone una questione fondamentale di sistema: quale valore ha una norma che la stessa Corte ha ritenuto non conforme alla Costituzione, ma che continua a essere vincolante? La dissonanza tra la motivazione e il dispositivo può creare ambiguità applicative, e rischia di generare una zona grigia in cui la norma è e non è, vincolante e al tempo stesso disapplicabile.
Da un lato, tale modello risponde all’esigenza di evitare decisioni manipolative prive di “rime adeguate”. Dall’altro, tuttavia, rischia di minare il ruolo stesso della Corte come custode della legalità costituzionale. Se il riconoscimento dell’illegittimità non è accompagnato da una pronuncia sanzionatoria, il sistema rischia di cristallizzare una forma di incostituzionalità tollerata. Si genera una frizione tra il principio di legalità e quello di effettività della tutela dei diritti.
I Principi Internazionali del Diritto
Disapplicazione, sospensione, monito: le strade aperte per il giudice comune
Quali strade ha, oggi, il giudice chiamato a convalidare un trattenimento ex art. 14 TUI?
- Applicazione della norma: continuare ad applicare la disciplina vigente, pur sapendo che è costituzionalmente inadeguata.
- Nuova questione di legittimità: sollevare nuovamente la questione, valorizzando l’inerzia legislativa successiva al monito.
- Sospensione cautelare: adottare misure ex art. 700 c.p.c. per tutelare i diritti fondamentali del trattenuto.
- Disapplicazione indiretta: rigettare la convalida sulla base del difetto di legalità sostanziale.
Ognuna di queste opzioni comporta implicazioni delicate. La prima rischia di tradire la funzione garantista del giudice. La seconda potrebbe generare una moltiplicazione dei giudizi di legittimità. La terza fornisce una tutela solo cautelare. La quarta rischia di introdurre una sorta di controllo di costituzionalità diffuso non previsto dal sistema.
Vi è infine una quinta possibilità, non espressamente codificata, ma sempre più discussa in dottrina: l’adozione di una forma di resistenza interpretativa. Il giudice potrebbe infatti dar vita a un orientamento che, pur applicando formalmente la norma, ne svuoti il contenuto lesivo mediante un’interpretazione conforme a Costituzione, riducendo il trattenimento alle sole ipotesi e modalità chiaramente definite e rispettose dei diritti fondamentali.
Verso una nuova stagione della legalità costituzionale?
La sentenza n. 96/2025 apre una nuova stagione del diritto costituzionale, in cui la Corte non si limita a cancellare norme, ma invita il legislatore a ricostruire, rammendare, ricomporre. Ma mentre il legislatore temporeggia, il giudice è lasciato solo davanti alla frattura tra legalità formale e sostanziale.
Le implicazioni di questa frattura sono enormi: per la tutela dei diritti fondamentali, per la certezza del diritto, per la legittimità dell’intervento pubblico in materia di immigrazione. Occorre, quindi, che il monito della Corte non resti lettera morta, ma si traduca in un intervento legislativo tempestivo, coerente e rispettoso della Costituzione.
Fino ad allora, la giustizia sarà costretta a muoversi in un territorio incerto, tra norme vigenti e principi disattesi, tra legalità formale e sostanza costituzionale. La sentenza n. 96/2025 è, in definitiva, una sentinella: segnala un pericolo, non lo neutralizza. Sta ora al legislatore, ma anche alla comunità giuridica, accogliere il segnale e tradurlo in azione.
La Relazione alla Sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 2025